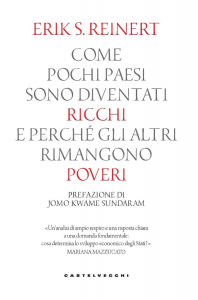 Erik S. Reinert
Erik S. Reinert
COME POCHI PAESI SONO DIVENTATI RICCHI E PERCHÉ GLI ALTRI RIMANGONO POVERI
Edizioni Castelvecchi, pp. 379, € 29
Traduzione di Monica Di Fiore
“Tradizionalmente, la ricchezza e la povertà sono state spiegate riconoscendo che le diverse attività economiche sono considerate vettori di ricchezza diversi dal punto di vista qualitativo, una prospettiva che si è persa nell’odierna teoria dominante, anche se le economie dei paesi poveri assomigliano molto più alle condizioni supposte normali nei manuali di economia di quanto non lo siano le economie dei paesi ricchi” (p. 64). Cominciamo con questa lunga frase a spiegare un testo che cerca, in maniera abbastanza comprensibile, di illustrare l’ovvietà che è sotto gli occhi di tutti; e cioè che i paesi ricchi hanno conquistato nel corso del tempo le leve dominanti dell’economia mondiale e le stanno usando, forse inconsapevolmente, per mantenere la maggioranza dei popoli in condizioni di povertà e quindi di sudditanza.
Secondo la teoria economica dominante tutte le attività economiche si equivalgono dal punto di vista del valore: un’ora di lavoro di un programmatore della Apple è uguale a un’ora di lavoro di un contadino indiano. Il presupposto, falso, su cui si basa la teoria economica dominante è quella della concorrenza perfetta abbinata a un rendimento crescente. In un mondo ideale le persone che concorrono all’ora di lavoro Apple sono uguali a quelle che vanno a lavorare nei campi indiani, e in entrambi i casi il rendimento che si ricava dal lavoro è crescente al crescere del tempo impiegato. Nella realtà però sono sicuramente meno le persone qualificate a lavorare alla Aplle ed il lavoro nei campi rende spesso in maniera inversamente proporzionale al tempo dedicato, oltrepassato un certo limite. Diciamo allora che nella realtà l’economia funziona con principi di concorrenza imperfetta – i punti di partenza dei concorrenti non sono mai uguali – e che a seconda del prodotto lavorato si va spesso incontro a rendimenti decrescenti. Le dinamiche che hanno portato a strutturarsi il mondo moderno fanno sì che “le esportazioni dei paesi ricchi contengono gli effetti buoni – rendimenti perfetti e concorrenza imperfetta – mentre le esportazioni dei paesi poveri contengono, all’opposto, gli effetti cattivi” (p. 65).
La teoria cui si riferisce l’autore è detta Other Cannon, opposta all’economia neoclassica che va per la maggiore, e si basa più sull’osservazione dei fatti e della storia che su regole matematiche (cfr. p. 90 sgg). Le regole matematiche sono il fondamento delle politiche neoliberiste alla base delle scelte del Fondo Monetario Internazionale (FMI). La storia delle teorie economiche può essere fatta partire da Antonio Serra, un economista italiano che già nel 1613 proponeva una teoria dello sviluppo economico diseguale, osservando le differenza economiche tra Napoli e Venezia. Napoli, città ricca di materie prime, stava diventando sempre più povera mentre Venezia, che basava tutta la sua economia sul commercio e sulla trasformazione delle materie prime, era il centro economico dell’Europa. Le differenze qualitative delle diverse attività economiche sono centrali per spiegare lo sviluppo capitalistico delle singole nazioni o regioni. A partire dal ‘600 varie teorie hanno cercato di spiegare lo sviluppo economico. Le più famose sono quella di Ricardo, di Smith e di Marx. Secondo l’autore di questo libro la teoria di Marx è una teoria di Ricardo semplificata; tutte queste teorie vanno fatte rientrare nell’ambito dell’economia classica, che “suppone l’essere umano come una tabula rasa, mirante esclusivamente al principio del piacere i cui risultati si ottengono con il baratto; la teoria continentale suppone invece un uomo motivato più dalla volontà di sapere e di produrre, ottimizzando le proprie capacità” (cfr. p. 114 sgg).
Storicamente la forma economica più importante dell’età moderna, il colonialismo, ha lasciato traccia nel presente nella divisione tra paesi produttori di materie prime (i paesi poveri) e paesi trasformatori di materie prime e conoscenza (i paesi ricchi): dato che questa ripartizione dei compiti si è realizzata storicamente, è difficile immaginare un nuovo assetto in cui non si dia più e che permetta un equilibrio nei livelli di sviluppo. Infatti “una nazione che voglia acquisire un certo potere economico deve orientarsi alla messa in atto del piano della cosiddetta tripla rendita: un potente settore industriale, un monopolio delle materie prime e un forte commercio estero. Questo esempio parte dalla politica estera inglese del 1485 (Enrico VII) ma si può estendere anche ai moderni paesi detentori del petrolio” (cfr. p. 143 sgg). Dopo la politica illuminata del sovrano inglese, il controesempio l’abbiamo dalla Spagna, che con la scoperta delle Indie Occidentali iniziò un periodo di involuzione: “all’opposto dell’Inghiletrra, la Spagna è l’esempio della politica da non tenere. Partendo da una posizione dominante nel 1400, la Spagna è pian piano regredita in virtù di una politica economica incentrata sull’importazione di beni dalla colonia e sul mantenimento dell’agricoltura come forza economica primaria” (cfr. p. 148 sgg). Gli esempi storici di Spagna e Inghilterra valgono a validazione dell’assunto base del testo, ovvero che “il capitalismo deve essere essenzialmente inteso come un sistema di conseguenze non intenzionali” (p. 150).
Sia a sinistra sia a destra il capitalismo viene inteso come un modello economico basato sull’industrializzazione: senza industria non c’è crescita di ricchezza, e se non c’è crescita non ci può essere ridistribuzione tra le fasce sociali. La centralità dell’industria venne però messa tra virgolette già con il lavoro di Smith che equipara le ore di lavoro del commercio alle ore di lavoro della produzione. Ogni differenza tra le nazioni sarà motivata dalla quantità del lavoro profuso e non dalla qualità dei prodotti generati: “Una catena di eventi, a discapito dei paesi poveri, portò l’economia ad abbandonare la definizione di capitalismo di Sombart. Adam Snith aveva rimosso la produzione dall’economia, combinando sia il commercio sia la produzione nelle ore di lavoro. Così, quando l’economia mondiale fu concepita come un sistema in cui tutti si scambiano ‘ore di lavoro’ indefinite, senza tecnologia, senza economie di scala e senza effetti di sinergia – un lavoro che tutti padroneggiano allo stesso modo – si spianò la strada all’idea che il libero scambio potesse essere considerato vantaggioso per tutti. Anche l’aggiunta di capitale di per sé non crea il capitalismo. Tuttavia, per lungo tempo gli economisti americani e dell’Europa centrale erano riusciti a mantenere viva una tradizione economica alternativa, il cui centro era la produzione” (p. 189). Le politiche di aiuto dei paesi ricchi risentono pesantemente di questa impostazione concettuale: “L’occidente ha iniziato a pensare che inviando capitali in un paese povero senza imprenditoralità, senza politica governativa e senza sistema industriale, avrebbe potuto produrre il capitalismo” (p. 191). Un vero capitalismo si può ottenere solo con il rispetto delle regole della tripla rendita. Gli aiuti all’alfabetizzazione a paesi che non hanno le strutture per impiegare i pochi alfabetizzati, avrà come sola conseguenza un aumento dell’immigrazione economica con un flusso di ritorno (money transfer) degli immigrati verso i paesi d’origine. A dir poco, un serpente che si morde la coda, simbolo perfetto dell’immobilismo e dell’immutabilità delle cose. È la trasformazione delle cose e la presa di possesso dei beni forniti dalla natura che permette di andare avanti; il crollo dell’economia messicana a seguito degli accordi del NAFTA è dovuto appunto alla dismissione di industrie a ciclo completo (progettazione, trasformazione, commercializzazione) per ridursi a luogo di assemblaggio di prodotti esteri, fondamentalmente americani. Le politiche protezionistiche dei paesi ricchi hanno come conseguenza lo scoraggiamento all’impianto di industrie produttive nei paesi poveri; e senza questo passo, tali paesi diventeranno sempre più poveri.
“Le innovazioni e non il risparmio e il capitale di per sé, guidano il benessere. (…). L’economia globale può essere vista come una sorta di schema piramidale – una gerarchia di conoscenza – in cui coloro che investono di continuo nell’innovazione rimangono all’apice del benessere” (p. 216). I soldi che le economie ricche devolvono allo sviluppo delle povere se dati in assenza di una struttura produttiva adeguata trasformano i paesi che li ricevono in economie sussidiate, che il minimo cambiamento nelle regole di commercio mondiali possono sprofondare nella crisi. Il punto è che “l’occidente ha iniziato a pensare che inviando capitali in un paese povero senza imprenditoralità, senza politica governativa e senza sistema industriale, avrebbe potuto produrre il capitalismo” (p. 191). Il problema globale si delinea come un problema essenzialmente politico. In assenza di un piano programmatico a lunga scadenza nessun paese riuscirà a tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui la globalizzazione l’ha sprofondato; questo perché la globalizzazione è un sistema che privilegia come valore assoluto la circolazione delle merci piuttosto che l’aumento del reddito della singola nazione. E questa non è un’osservazione da poco. Si aggiunga poi che le regole del commercio, così come vengono messe in atto, “rendono estremamente difficile la creazione di paesi a reddito medio” (p. 234).
I paesi ricchi sono spinti a diventare sempre più ricchi e questo toglie ogni possibilità d’agire ai paesi poveri: “questa visione della povertà basata sulla distribuzione….(ha come punto debole) che affronta la povertà non cercando di migliorare la capacità di creare la propria ricchezza, ma ridistribuendo il reddito creato altrove” (p. 270). Giunti alle ultime battute del libro il nostro autore sottolinea un problema cruciale: per gli economisti non è possibile “rivendicare alcuna freccia di causalità che vada dalla struttura economica alla politica” (p. 288). In altre parole sopravvive il presupposto ideale che il governo possa orientare al bene i suoi cittadini, trascurando il fatto che è quanto bene i cittadini vivono che dà alla politica la possibilità di condurli da qualche parte. In assenza di benessere diffuso la politica si trasforma in gestione privata dei beni (scarsi). Questo stato di cose è ben visibile in tutti i paesi poveri nei quali la corruzione e il malgoverno la fanno da padrone.
Di fronte all’evidenza i governi dei paesi ricchi predispongono linee di intervento; all’inizio del nuovo secolo sono stati proposti i MDGS (Millennium Development Goals). “Dal punto di vista della teoria economica, i MDGS possono essere considerati come un sistema in cui le nazioni che producono con rendimenti crescenti pagano un compenso annuale per le loro perdite alle nazioni che producono con rendimenti costanti (o descrescenti)” (p. 334). Anche questi interventi rientrano nella dinamica dell’economia palliativa, che l’occidente propone ai paesi poveri come unica via di sopravvivenza. Non viene in effetti avanzata alcuna linea politica che possa dotare le nazioni povere di industrie funzionanti, il solo strumento che permetterebbe un riequilibrio della situazione. Le nazione povere non dovrebbero commerciare con nazioni ricche, ma solo con nazioni che hanno uno stesso livello di sviluppo tecnologico; senonché queste nazioni hanno poco da scambiarsi (cfr. p. 359). Siamo all’interno di un circolo vizioso che solo un radicale mutamento di paradigma potrebbe mutare.
In ultima analisi ci pare il caso di avanzare addirittura l’ipotesi di un pregiudizio antropologico da parte delle nazioni ricche: i poveri sono poveri per colpa loro, per dove nascono, per la situazione ambientale e culturale in cui crescono. I poveri non han voglia di lavorare. A questa banale ed erronea opinione popolare, il nostro autore oppone le osservazioni di un economista tedesco, J.J. Meyen, che già nel 1770 scrisse questa parole. “È noto che le nazioni primitive non migliorano i loro costumi e le loro tradizioni per trovare, in seguito, industrie utili, ma il contrario” (p. 370). La strada da percorrere è nota, ma è il contrario di quella che stiamo percorrendo, e ciò rende difficile anche il semplice vederla. Questo saggio è un utilissimo strumento per aprire gli occhi.