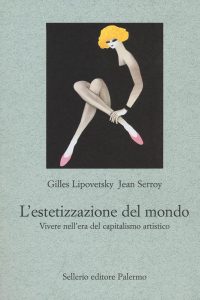 Gilles Lipovetsky e Jean Serroy
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy
L’ESTETIZZAZIONE DEL MONDO
Edizioni Sellerio, pp. 351, € 20,00
Traduzione Andrea Inzerillo
Questo saggio parla di aspetti molto concreti della vita di ognuno, tanto concreti che ognuno potrebbe averci già fatto un pensierino sopra, se è uno che fa dei pensierini, perché è vero che non tutti li fanno, i pensierini, anche se questa considerazione è forse più mia che non degli autori del libro, due che sembrano più aperti/positivi sugli influssi che l’estetizzazione progressiva del mondo può avere sulle persone, rispetto al loro grande conterraneo Debord e alla scuola di Francoforte, che, ricordiamolo, avevano posizioni molto pessimiste sugli influssi che la società dello spettacolo aveva sulle persone. Questa affermazione è asseverata, mi piace usare parole desuete che in un saggio filosofico però ci stanno proprio bene, trattandosi di una materia desueta come la filosofia, da una frase che troviamo in apertura, e precisamente questa: “Nella misura in cui crea un paesaggio economico mondiale caotico utilizzando l’universo del quotidiano, il capitalismo somiglia più a un Giano bifronte che a un mostro che divora i suoi figli” (p. 21), e la posizione del mostro è quella di Debord e, in parte, della scuola di Francoforte, ma non è questo il luogo per entrare nei dettagli, chi vuole i dettagli può andarsi a leggere la recensione della Società dello spettacolo o della Dialettica dell’illuminismo, mentre i nostri due autori cercheranno di farci vedere come il nuovo capitalismo estetico sia come Giano, quindi con due facce, ma che noi consumatori possiamo vedere contemporaneamente, perché siamo, almeno in parte, consapevoli che insieme al bello il capitalismo estetizzato ci rifila un sacco di paccottiglia. Questo è dovuto al fatto che l’arte ha cambiato il suo ruolo nella vita quotidiana, perché prima l’arte non entrava tutti i giorni nella vita, che era fatta dalle cose di tutti i giorni, svegliarsi lavorare mangiare dormire etc..; oggi ognuno di noi cerca di mettere un pizzico d’arte in quello che fa, il più possibile ovviamente, ma purtroppo non sempre è possibile, dipende da come ti svegli, dove lavori, cosa mangi e con chi vai a dormire, ma tant’è, lo sforzo verso l’arte ci accomuna tutti, chi più chi meno. Sperando di essere tra quelli di più, un’osservazione che troviamo a pagina 37 riassume questo stato di cose:” Più l’arte entra nel quotidiano e nell’economia, meno si fa carico di alti valori spirituali.” Questa è per certi aspetti una nuova forma d’arte, meno sacra e valoriale, più superficiale e di consumo e chi la produce è assolutamente consapevole dello stato delle cose, e la sua consapevolezza produce un’arte che è forse meno arte ma più in grado di affascinare il pubblico vasto; l’estetica del nuovo capitalismo raggiunge un pubblico più ampio ma lo fa con prodotti più omogenei, più prevedibili. Questo non significa comunque, a detta degli autori, che il pubblico sia massificato, perché all’interno della massa ogni individuo tenta una sua strada personale verso il prodotto estetico. Siamo quindi di fronte all’unione di una dimensione personale, volitiva, ed una industriale, organizzativa. Questo nuovo capitalismo estetico si caratterizza dunque con tratti distintivi rispetto al passato, ovvero:
1 l’estetica diventa strategica o ingegneria dell’incanto, perché cerca di riprodurre l’incanto (naturale) attraverso una strategia (artificiale),
2 le opere sono giudicate in base a quanto rendono più che in base al valore estetico e quindi il valore estetico è anche un valore commerciale, senza però che questo valore commerciale possa soppiantare l’estetico
3 non esistono più realtà piccole che producono arte perché il fenomeno ha carattere transnazionale o meglio, e questo lo dico io, appena una piccola realtà produce arte salta fuori una realtà più grossa che se la pappa per mettere a frutto commercialmente le intuizioni estetiche del piccolo e, per finire,
4 c’è una perdita dei confini tra le sfere economica e artistica (cfr. pp. 47-48).
Ho riassunto in maniera abbastanza semplice questi quattro punti attorno ai quali si svilupperà tutto il libro, e quindi se siete stanchi potete piantarla qui, potreste avere già capito tutto. Se invece avete voglia di proseguire, il prosieguo, bella parola, sarà svolto a partire da singole frasi del libro che cercherò di inserire in un discorso più ampio, data la mia innata tendenza verso lo strutturalismo.
Ad esempio, a pagina 53, i nostri osservano che: “Negli anni Sessanta un film aveva una vita in sala di due o tre anni; oggi (…) l’80% dell’incasso viene realizzato nei primi 15 giorni dall’uscita” che è un dato che fa riflettere, sempre che vogliate riflettere, e che sta ad indicare come il capitalismo estetico sia diretto verso una sempre maggiore accelerazione della circolazione delle merci, favorito in questo dalla progressiva smaterializzazione delle stesse, perché è ovviamente più facile far girare velocemente dei dati digitali che non 10 bancali di lp (leggi ellepi). A pagina 59 troviamo che “… il turismo è diventato la prima industria al mondo e rappresenta circa il 12% del PIL mondiale”, che è un dato impressionante ma che si spiega con il fatto che la maggior parte dell’esperienza estetica è diventata un’esperienza di superficie e cosa meglio del viaggio può rappresentare la superficialità, perché pochi viaggiano come Chatwin, i più viaggiano come Fantozzi e, sempre sperando che chi legge sia come Chatwin e non come Fantozzi si arriva a pagina 62 dove scopriamo che “… il mercato dell’esperienza rappresenta la nuova frontiera del capitalismo.” Il capitalismo estetico quindi non ci vende più solo oggetti, cosa vera fino agli anni ’50, ma esperienze. L’esperienza, come concetto, è infatti alla portata di tutti, è più democratica, chi è che non riesce a fare un’esperienza? Nessuno, tutti ci riescono e quindi tutti ambiscono ad acquistarla, senza rendersi conto che l’esperienza non si può acquistare perché va fatta costruendola a partire dalle proprie capacità; già, ma se le capacità non le hai sviluppate, o magari non ne eri dotato, che si fa? Resti tagliato fuori? No, “Unico nel suo genere, il capitalismo artistico ha dato vita a un’arte di consumo di massa che non richiede nessuna cultura specializzata”(p. 68). Ora, se nessuno ha bisogno di una cultura specializzata per fare esperienza artistica, il capitalismo estetico, o meglio transestetico come lo definiscono i nostri, è un evento che ha cambiato più radicalmente la realtà di tutti i movimenti avanguardisti di inizio novecento: da cui: “Oggi c’è molta più rivoluzione nell’economia che nell’arte: è il capitalismo artistico a cambiare il mondo, non più l’arte d’avanguardia” (p. 81).
L’arte d’avanguardia nasce in un periodo in cui di arte ce n’era poca e in quella poca ancora di meno era d’avanguardia: oggi, che tutti sono artisti, d’arte ce n’è d’avanzo e quasi tutta l’arte è d’avanguardia, che un artista si vergogna se gli dicono che è classico, perché classico è vecchio, e allora è meglio essere all’avanguardia, ma nessuno più si cura della mancanza d’orizzonte, e senza un orizzonte non c’è avanguardia; ne risulta che quasi tutta l’avanguardia d’oggi è fuffa. L’avanguardia di un tempo aveva uno scopo, una finalità, scopo e finalità intrinseci al programma modernista, che era un programma volto al disvelamento della realtà nascosta alle masse. Oggi di realtà nascosta sembra non ce ne sia più, ma questo non è vero e ci torneremo dopo, se mi ricordo, e questo è uno dei punti che più minano alla base la sopravvivenza di un’arte in senso modernista. Oggi l’arte è velocità più novità più stupore, sorpresa; “Il culto del nuovo e dell’espressione soggettiva ha preso il posto della funzione di rivelazione ontologica che i moderni attribuivano all’arte” (p. 102). Persa ogni funzione ontologica, l’arte viene precipitata al livello di ogni altro bene di consumo. Questa banalizzazione dell’arte ha un significato antropologico, ovvero rivela come il capitalismo abbia imposto nuove forme valoriali alla società umana, molto più che non le varie tentate rivoluzioni, artistiche o meno. Questa evoluzione antropologica è passata attraverso tre fasi; noi, che viviamo nell’ultima, che sarebbe la terza, non ci ricordiamo più cosa succedeva nella prima e nella seconda ed alcuni rimpiangono la seconda, che sono poi quelli che dicono si stava meglio quando si stava peggio, frase stupida quant’altre mai e che rivela un’intima natura fascista del parlante, ma lasciamo perdere, quello che conta è che gradualmente si è persa di vista l’importanza della realtà materiale per rivolgersi al suo aspetto estetico; ci siamo dimenticati, in altre parole, che non è tutt’oro quel che luccica. L’affermazione dei centri commerciali e delle catene distributive è la prova di quanto detto, oltre alla frase a pagina 115, che riporto per dovere di cronaca, o meglio per dovere di commento, perché questa è una recensione e non un articolo di giornale: “Una bottega era ricca se i prodotti che offriva erano di qualità o di lusso, non per la teatralità o l’eleganza dello spazio commerciale” (p. 120). Tutta questa seconda parte è dedicata all’illustrazione, attraverso esempi, di come si sia affermata l’estetizzazione dell’esperienza, di cui avevo già richiamato l’importanza nella prima; ma gli esempi portati non vanno tutti in un’unica direzione, non pare cioè essere all’opera un modello unico di globalizzazione estetica. In alcuni campi l’estetizzazione è dominante, in altri no, o meglio, visto il numero di persone coinvolte in questo processo, ciascuno persona sceglie individualmente, anche in base alle proprie capacità economiche, a quali campi riservare un atteggiamento prevalentemente estetico e a quali uno prevalentemente economico (cfr p. 136 e sgg.). Possiamo dire che da una cultura orientata verso il futuro tipica della prima modernità si è passati a una società presentista dominata dalle nuove forme di godimento, di svago, di soddisfazione immediata. Inutile dire, però lo dico perché a me sembra utile, che in una società siffatta poche sono le possibilità di assistere ad una rivoluzione di massa. L’idea che ci sarebbe stata una rivoluzione, proletari di tutto il mondo unitevi, nasceva dal fatto che l’applicazione rigida dei principi del capitalismo avrebbe creato una massa di scontenti che, unitisi e presa coscienza della propria condizione, avrebbero smantellato dall’interno questa struttura. Ma il capitalismo sì è dimostrato furbo e adattabile, più furbo e più adattabile di tanti che credono ancora ai principi del marxismo sic et simpliciter, e ha creato una nuova struttura culturale che è anche economica e che con le sue regole implicite scoraggia ogni forma di ribellione; anzi, più che scoraggiarla la rende di fatto impossibile perché ne mostra l’inutilità/stupidità. Viviamo un momento storico caratterizzato da quella che Toqueville chiamava uguaglianza immaginaria, che tende ad annullare ogni differenza intrinseca ad oggetti e persone; così facendo però annulla anche ogni criterio di organizzazione. Entriamo così nella caoticità del postmoderno (cfr. p. 205). Un esempio della caoticità che tutto sovrasta l’abbiamo dall’onnipresente concetto di ibridazione. Una branca dell’arte, un settore del commercio, una zona turistica ormai morte perché vecchie o stanche o tutt’e due, si mischiano con un’altra organizzazione di un settore merceologico lontano nello spazio e/o nel senso e danno luogo, appunto, ad un’ibridazione, che è un modo fine per dire una scempiaggine, ma tant’è. Scopo dell’ibridazione è sorprendere e catturare l’ormai smaliziato consumatore d’arte del tardo capitalismo estetico. Peccato che questa sorpresa duri poco e quindi il capitalismo transestetico debba sempre rilanciare con spettacoli più estremi e quindi meno artistici (cfr. p. 207 sgg). Tra le varie forme di spettacolarizzazione messe in campo c’è la possibilità di riconsumare esperienze del passato. Abbiamo così “ il cosiddetto consumo nostalgico (che) è una delle figure del consumo emozionale o esperienziale tipico della fase 3. Da questo momento in poi il consumo ci prospetta piaceri ed esperienze emotive di cui entra a far parte anche la nostalgia” (p. 211), e infatti Albano e Romina dicevano bene nostalgia canaglia. Questo significa che il capitalismo è passato da una fase originaria, in cui considerava solo il funzionamento della macchina, che doveva sempre andare, sempre funzionare e sempre produrre, ad una fase più evoluta in cui il soggetto deve entrare a far parte dell’accrocchio prodotto della macchina pensata dal design. So che è brutto da dire, ancor peggio pensarlo, ma la nostra epoca ha segnato il definitivo assorbimento della specie umana all’interno delle macchine che ha creato. Per capire meglio questo punto, oltre a richiamarmi alla frase che i nostri lasciano scritta a pagina 214, ovvero “Prendendo in considerazione le sensazioni e la soggettività del consumatore, il design passa da un approccio macchinico e tecnocentrico a una problematica olistica e antropocentrica”, invito i pochi che avessero voglia ad andare a dare un’occhiata ad un vecchio lavoro di Gunther Anders, ovvero L’uomo è antiquato volume primo e L’uomo è antiquato volume secondo.
La domanda che si pongono i nostri autori è ovvia a questo punto, ovvero i nostri si chiedono se Il soggetto del mondo dello spettacolo è attivo o passivo e scelgono di privilegiare la visione positiva, opponendosi e Debord e Adorno (cfr. p. 226). Questo fatto non sorprende, se consideriamo il momento storico in cui vissero questi due filosofi. I danni creati dalla naturale degenerazione dell’illuminismo spinsero sia Adorno sia Debord alla ricerca di un colpevole e, dato che entrambi erano marxisti il colpevole non poteva essere il singolo, doveva essere il sistema, che nella vulgata è come dire che non è colpa di nessuno, ma per Adorno e Debord non è così, perché in quanto filosofi sanno che la colpa è un concetto da rifiutare. Occorre un’analisi strutturale ed economica che mostri gli attori in gioco e quanta poca libertà di manovra sia lasciata al singolo dati gli attori. I nostri due contemporanei invece credono, al contrario, che proprio dati gli attori ai singoli sia data una grande opportunità di libertà e con questo non possiamo, noi che scriviamo che poi son sempre io, il vostro solerte libraio, non essere d’accordo. La libertà però va usata con consapevolezza, non accazzo. I nostri due, con una notevole conoscenza del mondo contemporaneo nelle sue sfaccettature commerciali, proseguono con l’esempio dei musei, dicendo che non sono “più templi che vogliono creare aura, ma musei dalle forme spettacolari che celebrano più l’universo del tempo libero e dell’intrattenimento che la sacralità dell’arte come in passato” (p. 232) Ecco un esempio della cessione della missione ontologica per ottenere il successo commerciale. Il punto però sta proprio nel capire quanto al successo commerciale possa abbinarsi una dimensione ontologica, anzi, quanto l’ontologia intrinseca all’opera d’arte possa condizionarne il successo commerciale. Secondo me, e basta guardare ai vari eventi di richiamo culturale sparsi per il mondo, la caoticità dominante si conferma appieno. Hanno successo eventi culturali a valore 100 come a valore zero. Altro problema, più spinoso e di ancor più difficile soluzione, è cogliere il fenomeno dal punto di vista del soggetto; per costui è importante l’arte racchiusa nell’oggetto artistico o il fenomeno spettacolare cui, partecipando, ci si sente di appartenere? “Non consumiamo più soltanto prodotti, film, luoghi turistici, musei: consumiamo lo spettacolo della celebrità come modo per incantare, per singolarizzare-personalizzare-affettivizzare un mondo impersonale come quello tecno-commerciale” (p. 235). Pare quindi che “l’importante non è più il senso, ma l’esperienza divertente del diverso, un mero vedere, un sentire istantaneo che passa subito a qualcos’altro” (p. 238). Il costante passare ad altro, la costante presenza all’attenzione dei mass media hanno soppiantato l’attenzione per il prodotto e per la qualità del lavoro; o meglio, la necessaria attenzione alla dimensione massmediatica ha provocato un aggravio nella quantità di lavoro da svolgere per ottenere un prodotto che soddisfi comunque dei requisiti di qualità, segno evidente che parte della dimensione ontologica sopravvive all’interno della dimensione spettacolare. Ma occorre prestare attenzione, perché “nella società dell’iperspettacolo qualsiasi materia è buona per occultare il reale” (p. 253). Il fenomeno del Kitsch è un esempio di tale occultamento. Il Kitsch, condannato da ogni forma d’arte moderna, è giunto con l’ultima fase del capitalismo estetico, alla rivendicazione del diritto d’esistere: “Si sviluppa così una forma rivendicata di kitsch, quella che Susan Sontag chiamava camp, indicando con tale termine qualcosa di oltraggioso, inappropriato o talmente di cattivo gusto da risultare divertente” (p. 262). Nulla va escluso dal circuito del commercio, anche il brutto, il kitsch, si crea una legittima fetta di mercato. Il fatto che tale mercato non richieda competenze specifiche ha come effetto secondario quello di abbassare i generale gli standard qualitativi per affermarsi esteticamente sul mercato. Se cambiamo punto di vista possiamo, o meglio, possono i due che hanno scritto il libro, guardare al fenomeno con occhi diversi: “Non assistiamo al deperimento di massa della sensibilità nei confronti del bello, ma alla democratizzazione delle aspirazioni e delle esperienze estetiche” (p. 280). Ciascuno può essere artista per un giorno, diceva Andy Warhol; il problema però è che se ti abitui a pensare alla vita in termini prevalentemente estetici, rischi di restare molto deluso dal fatto che molta vita è assolutamente prosaica: “Viviamo quindi in una società in cui i consumatori dedicano quasi tutto il loro tempo libero ad attività che considerano di poco valore e da cui non traggono sempre una grande soddisfazione” (p. 318). L’inganno del dì di festa si perpetra a danno di quanti non hanno consapevolezza né delle proprie capacità né dei propri limiti. Seguendo le proprie capacità e rispettando i propri limiti ciascuno otterrebbe il massimo della felicità possibile, che però non basta, dato che ciascuno vuole la felicità in estratto, che però, essendo astratta, non capita a nessuno, tantomeno nei dì di festa: “La festa ormai non ha più nulla a che vedere con la trasgressione rituale dei divieti” (p. 321). Il passaggio ad una società in festività perenne come la nostra ha come conseguenza un innalzamento della soglia del divertimento. Si abbandona la società pauperistica, reale fino a metà novecento, e si entra in una società di abbondanza illimitata ma illusoria: “La società transestetica coincide con la squalificazione delle morali ascetiche a beneficio di un modello estetico dell’esistenza incentrato sulle soddisfazioni sensibili, immediate e rinnovate” (p. 323). La filosofia costruttivista di Debord e della scuola di Francoforte, dal primo Freud e di parte dei migliori filosofi del novecento ha dovuto soccombere culturalmente alla spinta alla banalizzazione di tutto operata dal capitalismo transestetico. “Sono lo spontaneismo e l’immediatezza dei desideri a contare, molto più del costruttivismo individualista della prima modernità” (p. 325). E’ brutto dirlo, ma a livello di massa è Rousseau che batte Voltaire, anche se a livello individuale Voltaire visse molto meglio di Rousseau.